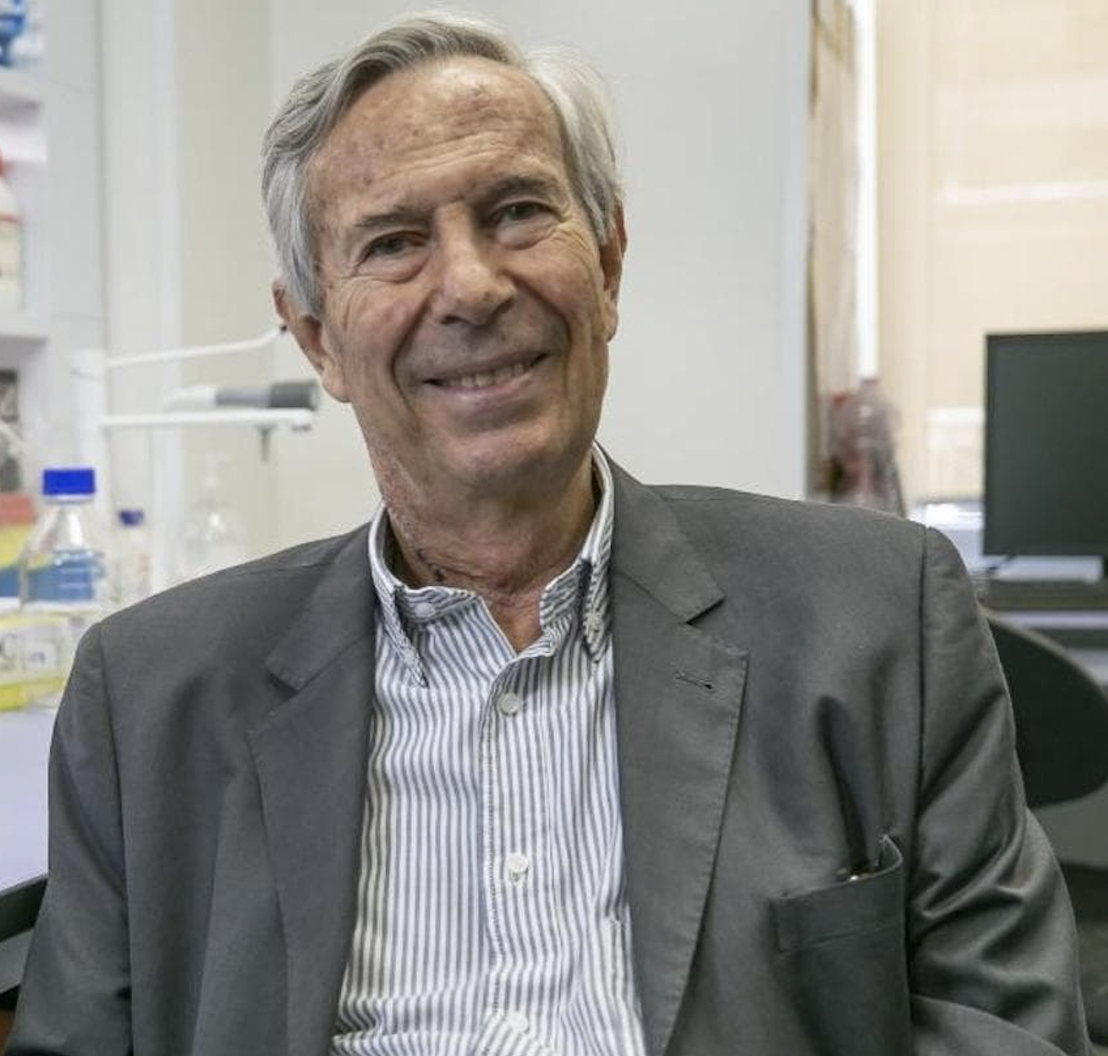“La vita non finisce con la morte. Quello che resta di te, è quello che trasmetti ad altre persone. L’immortalità non è il tuo corpo, che un giorno morirà. Non mi importa di morire. La cosa importante è il messaggio che lasci agli altri. Questa è l’immortalità”.
Le parole di Rita Levi Montalcini sono state prese alla lettera. La sua eredità è più viva che mai: lo dimostra una delle ultime scoperte dello European Brain Research Institute Riva Levi Montalcini (EBRI). I ricercatori di EBRI hanno, infatti, brevettato un vaccino, o meglio, un anticorpo monoclonale realizzato in laboratorio per bloccare l’Alzheimer. La nuova molecola che “ringiovanisce” il cervello è diretta contro un frammento di una delle proteine responsabili della morte dei neuroni, la tau. Verrebbe somministrato quando la malattia è già presente, non per prevenirla ma per arrestarne l’avanzare. Lo studio italiano – che nasce proprio sulla scia degli studi sul NGF (nerve growth factor) che permisero alla Montalcini di vincere il Nobel – effettuato su topi apre a nuove e significative frontiere di diagnosi e cura: i roditori, sottoposti a tale trattamento, hanno ripreso infatti a produrre neuroni ad un livello quasi normale.
Questa è solo una delle ultime intuizioni e successi dell’European Brain Research Institute, fondato nel 2002 dalla scienziata Premio Nobel e dal neuroscienziato professor Pietro Calissano, ed oggi rappresenta un centro di ricerca non-profit di fama internazionale dedicato alla comprensione delle funzioni cerebrali superiori, attraverso lo studio del cervello a vari livelli, dalle molecole, alle sinapsi, alle cellule nervose e gliali, ai circuiti neuronali fino al comportamento.
Con One Health, abbiamo avuto l’onore di intervistare in esclusiva il professor Calissano, con cui abbiamo ripercorso la grande scoperta dell’NGF, le origini dell’Istituto e le nuove sfide della ricerca, in un emozionante viaggio tra presente e futuro, all’insegna dell’eccellenza italiana in campo medico scientifico.
Professore, con Ebri, lo European Brain Research Institute, lei porta avanti i valori e la missione di Rita Levi Montalcini. Quali sono storia, esperienza e mission dell’istituto di ricerca a carattere internazionale?
Nel 2001 Rita, con la quale avevo un rapporto di collaborazione iniziato quattro decenni prima come postdoc, proseguito in seguito come collaboratore ed amico, lanciò una sorta di OPA per le neuroscienze centrato, in particolare, sui meccanismi di sviluppo del cervello e delle malattie degenerative che lo colpiscono. L’idea, presentata durante il convegno annuale che si tiene a Cernobbio, fu accolta con molto interesse da parte di alcune strutture pubbliche a Varese, Torino e Roma.
Rita istituì una commissione di valutazione di merito, nella quale inserì alcuni scienziati prestigiosi ed anche il suo amico e collega Dulbecco. La commissione ritenne l’offerta, da parte del direttore del Santa Lucia, Luigi Amadio, di gran lunga la più attraente. Prospettava la creazione del futuro “European Brain Research Institute” (EBRI) in comodato d’uso, entro un’area di circa 10000 mq, sulla via Ardeatina. In quell’area si sarebbe trasferita anche la parte scientifica del Santa Lucia ed un istituto di Neurobiologia del CNR (Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare INMM) che allora dirigevo.

Nel 2002 nasceva l’EBRI, con la partecipazione politica e istituzionale anche di coloro che usualmente limitano il loro intervento ad un breve discorso sull’importanza delle neuroscienze ed un fervido augurio di successo. Poco dopo EBRI bandì 4 nuovi posti di ricerca, senza distinzioni di nazionalità e di genere, che furono valutati da un’apposita commissione e che in parte unirono le loro ricerche a quelle già in corso nel INMM e al Santa Lucia. Fondatori dell’EBRI furono, quindi, la stessa Levi Montalcini, il sottoscritto ed il dott. Amadio. Mi permetto di affermare, con un po’ di orgoglio, che in quegli anni si creò il più rilevante centro di ricerche sul cervello esistente in Italia. Poiché in esso erano presenti tre istituzioni di differente natura sociale con più di duecento ricercatori.
Quali le principali “conquiste” di Ebri?

Sarebbe troppo lungo enumerare tutti gli studi che, dopo la fondazione, vennero condotti all’EBRI. Potremmo riassumerli ricordando che ciascun “principal investigator” (PI) era libero di intraprendere le ricerche che riteneva più pertinenti ai suoi interessi scientifici purché fossero indirizzati a studiare le funzioni cerebrali e le malattie che lo colpiscono, con particolare riferimento a quelle di natura neurodegenerativa. Attualmente, nello spirito e nelle finalità dell’EBRI ricorderei quelle che rappresentano la continuazione dello stesso NGF, la cui scoperta condusse la scienziata a Stoccolma in occasione del conferimento del Nobel. Fra queste, mi limito a ricordare la linea di ricerca che tuttora perseguo con Giuseppina Amadoro ed il mio piccolo gruppo: la realizzazione dell’anticorpo monoclonale che abbiamo denominato 12A12 che nasce proprio sulla scia degli studi sul NGF.
NGF (nerve growth factor), la “molecola della vita” che valse il Nobel nel 1986 a Rita Levi-Montalcini. Questa scoperta ha rappresentato una rivoluzione in campo neuroscientifico e biologico. Quali le applicazioni, oggi?
Prima di ricordare le applicazioni vorrei ricordare che questa scoperta, insieme a quella dell’epidermal growth factor da parte di Stanley Cohen ha portato alla luce una nuova classe di molecole che modulano molte funzioni dell’organismo. Oggi il NGF è impiegato a livello locale per diverse patologie oculari, qui all’EBRI il prof Cattaneo ha sviluppato una variante del NGF denominato painless NGF che presenta il vantaggio di poter essere somministrata con marcata riduzione dei sintomi dolorifici che provoca la proteina fisiologica.
Penso che nel futuro assisteremo all’impiego del NGF e delle sue varianti per numerose altre patologie e per la cura del morbo di Alzheimer. Questo fattore di crescita era stato così denominato dalla Levi Montalcini per la sua azione di promuovere la crescita delle fibre nervose. La stessa scienziata aveva dimostrato che, se veniva rimosso dall’organismo tramite la somministrazione di un anticorpo specifico, le cellule morivano. Il fenomeno era stato denominato immunosimpatectomia e l’azione di protezione delle cellule nervose simpatiche da parte del NGF era ritenuto di natura trofica.

Con il mio gruppo di ricerca dimostrammo, molto tempo dopo, che l’azione trofica non era una semplice azione che potremmo definire “nutritizia” ma consisteva nel tenere bloccato un meccanismo molecolare denominato apoptosi. Si tratta di un meccanismo geneticamente presente in tutte le cellule, attivando il quale esse iniziano la propria autoeliminazione: un vero e proprio suicidio cellulare. È stato dimostrato che il programma di apoptosi ha lo scopo di eliminare cellule che sarebbero altrimenti dannose o addirittura mortali per l’organismo, ad esempio quelle che potrebbero dare inizio ad un tumore.
Anni dopo, quando eravamo all’EBRI, dimostrammo che in realtà l’azione trofica da parte del NGF non era una semplice, generica azione nutritizia, ma consisteva nel tenere bloccato il processo di produzione di un peptide altamente tossico, denominato beta-amiloide, che partecipava in modo determinante all’attivazione dell’apoptosi.
Come dunque da questi risultati scientifici si è poi arrivati a trattare il morbo di Alzheimer, che oggi, insieme alle demenze senili, colpisce una persona su tre?

Era ormai noto che l’amiloide costituiva la prima causa dell‘instaurarsi del processo neurodegenerativo del morbo di Alzheimer, e che il NGF costituiva un fattore di protezione delle cellule colinergiche cerebrali che svolgono un ruolo fondamentale nei processi cognitivi, tipicamente la memoria. Quindi, se veniva a mancare il supporto di NGF alle cellule colinergiche poteva attivarsi un circolo vizioso: apoptosi – beta amiloide – degenerazione di tipo Alzheimer.
Attualmente, si ipotizza che una delle cause dell’instaurarsi di questa malattia possa essere provocata proprio dalla mancanza di NGF alle sue cellule bersaglio, e si studia come far affluire al cervello l’NGF, che normalmente non ha accesso se iniettato fuori di esso. Un problema che sembrerebbe minore ma costituisce per ora un ostacolo maggiore. Una via di accesso che viene oggi perseguita è la somministrazione di NGF per via nasale tramite il collegamento di fibre nervose che collegano direttamente le vie nasali con il cervello.
Nei decenni molti sono stati i passi in avanti in merito a diagnosi precoce e cura, recentemente la scoperta del vostro vaccino: un anticorpo monoclonale realizzato in laboratorio e testato, fino ad ora solo sui topi. A che punto siamo oggi?
L’alternativa che abbiamo perseguito e che si sta rivelando molto promettente è cercare di produrre e isolare un anticorpo (un vaccino) che bloccasse la produzione dell’amiloide, responsabile primaria, anche se non ultima, della malattia. Come ho accennato, gli studi che attualmente stiamo svolgendo con la collega Giuseppina Amadoro, hanno condotto alla produzione di un anticorpo monoclonale (che impropriamente si usa denominare vaccino) che si dimostra molto efficace in animali di laboratorio che sviluppano la malattia. Ovviamente la strategia ottimale sarebbe quella di un’azione sinergica di somministrazione di NGF e dell’anticorpo che, di fatto, stiamo studiando, in collaborazione con il gruppo di ricerca diretto dal prof. Antonino Cattaneo.
Un istituto di ricerche sul cervello nato più di 20 anni fa con l’idea di promuovere la meritocrazia, di dare spazio ai giovani e alle donne. Qual è il valore della ricerca, oggi? E come è cambiato?

Lo spirito professionale fondativo della Levi Montalcini e, di conseguenza, dell’EBRI, era basato sulla meritocrazia. Non a caso, come ho accennato, i quattro project leader o PI dell’EBRI furono selezionati dopo un bando pubblicato sulla rivista Nature al quale parteciparono un centinaio di giovani ricercatori di molte nazionalità. Tra i quattro selezionati 2 erano giovani ricercatrici, una francese ed una italiana, ma residente all’estero, e 2 ricercatori, uno francese ed uno italiano che lavorava all’estero. Era convinzione della Levi Montalcini, espressa di frequente pubblicamente, che l’Italia fosse un paese ricco di talenti che spesso non potevano essere portati in luce o inseriti nel mondo produttivo. Un esempio, fu l’assunzione nel nostro laboratorio di due periti chimici, Luigi Aloe e Delio Mercanti, che successivamente si laurearono in biologia, una giovane sarta, Nadia Campione, ed una giovane casalinga, Teresa Ciotti, che furono inserite nel laboratorio di culture delle cellule nervose, imparando molto presto il metodo per isolarle dall’embrione di pollo e coltivarle per i nostri esperimenti. Potrei menzionare molti altri casi che svelerebbero una vera e propria attitudine della scienziata come “talent scout”.
Sulla nostra rivista abbiamo spesso descritto i giovani ricercatori italiani come delle “rising star”.
Personalmente, condivido la convinzione dell’esistenza in Italia di giovani pieni di talento che spesso non possono, o non riescono, ad emergere. Questa mia convinzione è ancora più amara a causa della constatazione che, spesso, quelli che riescono a raggiungere l’obiettivo si trasferiscono in altri paesi che offrono loro salari e possibilità che non trovano in Italia. All’amarezza professionale si aggiunge una considerazione socio-economica di solito poco menzionata: l’Italia impiega notevoli quantità di euro per portare un cittadino dalle elementari fino alla laurea e successivamente questa ricchezza viene, per così dire, regalata ad altri paesi che si trovano gratis un giovane spesso molto promettente.
Sono trascorsi i primi 100 giorni del paziente zero con il chip Neuralink nel cervello. È d’obbligo, dunque, chiederLe una riflessione sul rapporto che si innesta tra Intelligenza Umana e Intelligenza Artificiale. Siamo davanti a un’innovazione o a una trovata di marketing con grandi rischi e poche speranze?
Questo è un problema che richiederebbe una lunga analisi. Mi limito a poche riflessioni: non credo che l’IA rappresenti un pericolo ma in realtà sia una opportunità. Naturalmente deve essere regolata con norme severe e stringenti, come si fece ad esempio qualche decennio fa dopo la decodificazione del genoma umano. Non credo, comunque, che sia opportuno confrontare la intelligenza artificiale con quella umana. Sintetizzando banalmente, direi che la prima è sostanzialmente quantitativa, quella umana avrà sempre un carattere qualitativo, per certi versi unico ed irripetibile.
“Da queste biografie (ndr. della stampa e dei mass media) emergevano molte informazioni, anche dettagliate sulla sua vita privata e di lavoro, ma mi sembrava poco o nulla sulla persona reale, concreta, umana che avevo avuto il piacere e indubbiamente l’onore di frequentare quotidianamente per più di quattro decenni. Soprattutto, avevo l’impressione che da questi ritratti emergesse più il mito di un genio scientifico che una figura, ovviamente dotata di grande intelligenza, ma la cui cifra personale era piuttosto un misto di grandi capacità intuitive e di una totale, quasi monastica, dedizione al lavoro”: queste le sue parole, riprese dall’introduzione del suo libro “Rita Levi-Montalcini. Una vita fra i neuroni”. Per quarant’anni ha lavorato a stretto contatto con il Premio Nobel: com’è nato il vostro rapporto professionale?
Mi ero laureato a Genova in Medicina con una tesi sperimentale che avevo svolto nell’Istituto di Chimica Biologica su un enzima cruciale nella sintesi dell’emoglobina. Poco dopo la laurea un collega, Giorgio Mangiarotti, mi comunicò che una scienziata italiana di nome Levi Montalcini, che aveva incontrato alla Washington University, stava aprendo un piccolo centro di ricerche neurobiologiche a Roma e cercava qualche giovane laureato che fosse interessato a studiare una proteina denominata nerve growth factor. I miei studi di biochimica – a parte le mie modeste ma robuste competenze di proteine enzimatiche – mi avevano convinto che le malattie mentali gravi fossero dovute a qualche causa chimica. Mangiarotti mi aveva comunicato il numero di telefono della scienziata a Roma e così la chiamai per un incontro, comunicandole il mio interesse per tutto ciò che riguardava il cervello.

Mi diede appuntamento, pochi giorni dopo, nella lobby dell’albergo dove sarei sceso. Fui subito colpito da questo suo atteggiamento poco “baronale” (e che in seguito definii “americano”) che presupponeva, nel caso accademico italiano, un atteggiamento opposto tra docente e discente. Ho già descritto spesso il mio incontro con la Levi Montalcini che, ribadisco, avvenne nel 1965, ventuno anni prima del conferimento del Nobel alla scienziata. Voglio ricordare la semplice definizione di Rita da parte del grande scrittore Primo Levi “una fragile signora dal carattere di ferro e dal portamento di una principessa”. La figura, l’eleganza e il portamento da principessa mi colpirono immediatamente, il carattere di ferro lo sperimentai negli anni successivi. Dopo un colloquio di alcune ore mi offrì una borsa di studio ed un invito a leggere le ricerche già pubblicate, che lessi di ritorno a Genova.
Mi permetto di farne un modesto vanto se compresi l’importanza degli studi che aveva già compiuto in USA e la cui importanza non era in quegli anni sostanzialmente riconosciuta dal nostro mondo accademico, se non dal Presidente del CNR Vincenzo Caglioti che l’aveva invitata a creare, nel 1963, il piccolo centro di Neurobiologia del CNR. Dopo quell’incontro, e di ritorno a Genova, decisi di compiere due passi fondamentali della vita: unirmi formalmente con la persona che avevo conosciuto e amavo da tempo e trasferirmi nella città eterna. Il mio compito era quello di studiare il meccanismo tramite il quale il NGF induceva la crescita delle fibre nervose. Direi che, in qualche modo, ci stiamo ancora lavorando.